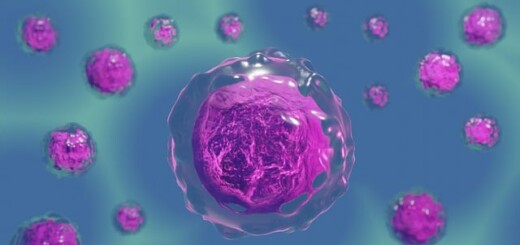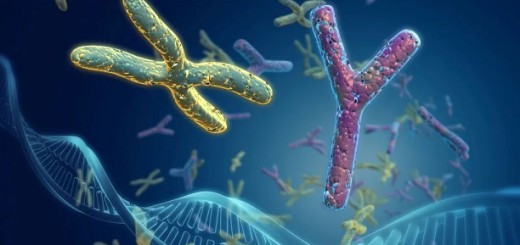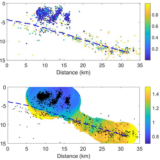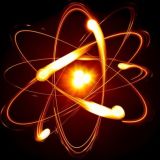“La dignità del vivere e del morire: dove comincia e dove finisce?”. La Lectio di Mons. Vincenzo Paglia per il “Graduation Day” dei Master in Cure palliative e terapia del dolore dell’Università Cattolica
Roma, 21 novembre 2018 – Dobbiamo prenderci cura l’uno dell’altro, non essere complici della morte. Lo ha ribadito mons. Vincenzo Paglia affrontando il tema “La dignità del vivere e del morire: dove comincia e dove finisce?” nella Lectio tenuta martedì pomeriggio per la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs (Aula Brasca), in occasione del Graduation day dei Master universitari di I e II livello in Cure palliative e Terapia del dolore dell’Università Cattolica.
Mons. Vincenzo Paglia è Presidente della Pontificia Accademia per la vita e Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia.
Mons. Paglia ha delineato in apertura l’ambito sociale e culturale in cui collocare il suo intervento: il progresso della medicina e delle cure mediche che allungano la vita, da un lato; dall’altro: la crescente richiesta di eutanasia come giustificazione per una “morte degna” e la solitudine del morente spesso abbandonato a se stesso. La vera questione – ha sottolineato mons. Paglia – è “di morire con dignità, non di anticipare la morte”.
“Il cristianesimo non predica l’amore della morte, né l’indifferenza al morire. Incoraggia però a circondarla da ogni lato con l’amore, per impedirle di trionfare sulla speranza della vita, per impedirle di nuocere. Il lato nichilistico della morte trionfa, invece, quando induce disperazione nei confronti dell’amore così da farlo apparire uno sforzo vano e senza senso”.
“Non si deve inoltre dimenticare che la domanda di eutanasia o suicidio assistito è nella quasi totalità dei casi figlia dell’abbandono terapeutico (e sociale) del malato. Una volta che si sia messa in atto una valida presa in carico multidisciplinare del paziente e coinvolta positivamente la famiglia nel processo di cura, è rarissimo trovarsi di fronte a una richiesta di morte”.
La ‘sfida’ è racchiusa nel “prendersi cura” delle persone con un atteggiamento di “prossimità responsabile”. “Stringere la mano di chi sta morendo è tra le più urgenti e profonde pratiche umane da riprendere. In genere di fronte alla morte si fugge, c’è una sorta di fuga generale, “ciascuno-per-sé”, per non sentire e soprattutto per non vivere nell’imbarazzo. Si preferisce la concentrazione su di sé alla vicinanza a chi ha bisogno. Ma non ne guadagniamo in libertà; al contrario, ci impoveriamo ancor più. Nessuno vorrebbe morire da solo. Tutti desideriamo di essere accompagnati nei momenti difficili, soprattutto in quello della morte”.
“Gli stessi medici e gli infermieri debbono essere educati all’ascolto e alla relazione con chi sta per morire. Certo, è alta la responsabilità dei parenti e degli amici di stare vicino a chi muore, a partire dalla più semplice delle relazioni, come appunto tenere strette le mani dell’altro. Dinanzi alla vertigine della morte, quelle mani strette hanno un valore inimmaginabile: significano legame, amore, sicurezza. L’amore che trasmettono quelle mani strette sino alla fine, o quelle mani che carezzano, che detergono, che aiutano, che lottano anch’esse contro il dolore e l’agonia, quelle mani stanno sconfiggendo la morte. La morte, in effetti, può mettere fine alla vita, non alla relazione. L’amore è sempre più forte della morte”.




 Salva come PDF
Salva come PDF